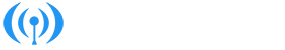la terza pagina di 'LuceraNet.it', a cura del prof. Alfredo A. Padalino.
La scuola italiana si trova da decenni al centro di una crisi di riconoscimento sociale: da un lato la perdita di prestigio degli insegnanti come figure pubbliche, dall’altro la progressiva femminilizzazione del corpo docente. Due dinamiche spesso trattate separatamente, ma che in realtà si intrecciano e si rafforzano a vicenda, generando un meccanismo di svalutazione che ha conseguenze profonde non solo sulla professione, ma anche sul ruolo politico e culturale dell’istruzione nella società.
La riduzione dell’insegnante a funzionario esecutivo ha reso la professione meno appetibile per chi cercava prestigio sociale e riconoscimento pubblico (tradizionalmente più uomini), mentre la massiccia presenza femminile è stata usata come ulteriore giustificazione per svalutare il ruolo.
In molte società occidentali, i lavori a maggioranza femminile sono sottopagati e meno riconosciuti: dalla cura all’insegnamento. In Italia la scuola ha assunto i tratti di un lavoro “di cura” più che di un lavoro “intellettuale”. E così, anziché valorizzare il contributo femminile alla formazione della cittadinanza, si è alimentata una spirale di marginalizzazione simbolica:
insegnante = donna;
donna = lavoro di cura;
lavoro di cura = poco prestigio.
Questa femminilizzazione, associata alla marginalità sociale del docente, produce anche un effetto simbolico: la figura maschile è spesso assente nei luoghi di formazione primaria e secondaria. Bambini e ragazzi crescono quindi in una scuola dove l’autorità è quasi esclusivamente femminile, ma allo stesso tempo socialmente svalutata. Ne deriva un paradosso: i docenti sono autorità quotidiane, ma prive di riconoscimento sociale, e ciò mina l’autorevolezza della scuola stessa.
Il fatto che la scuola sia stata resa un luogo femminilizzato e burocratizzato non è neutrale: significa neutralizzare la carica critica dell’istruzione. Se il docente non è più un intellettuale, ma un funzionario; se la professione è considerata “da donne”, quindi meno rilevante; se la sua parola pesa poco nello spazio pubblico, allora la scuola perde la sua capacità di generare coscienza critica e diventa davvero solo un servizio tecnico.
Restituire dignità e autonomia agli insegnanti significa anche rompere questo schema di genere:
riconoscere la scuola come lavoro intellettuale e politico, non come “cura minore”;
restituire valore a chi oggi tiene in piedi il sistema, cioè le donne, ma senza accettare che la femminilizzazione resti sinonimo di svalutazione;
rendere la professione attraente anche per gli uomini, non per “riequilibrare numeri”, ma per spezzare il circolo vizioso che associa femminilità e marginalità.
In questo senso, la questione degli insegnanti in Italia è al tempo stesso politica e di genere: la riduzione del docente a burocrate e la femminilizzazione del corpo insegnante sono due facce della stessa svalutazione sociale.
Restituire autorevolezza alla scuola significa restituire valore alla parola degli insegnanti, indipendentemente dal genere. Solo così l’istruzione potrà tornare a essere un pilastro critico e democratico della società, e non un semplice servizio amministrato.